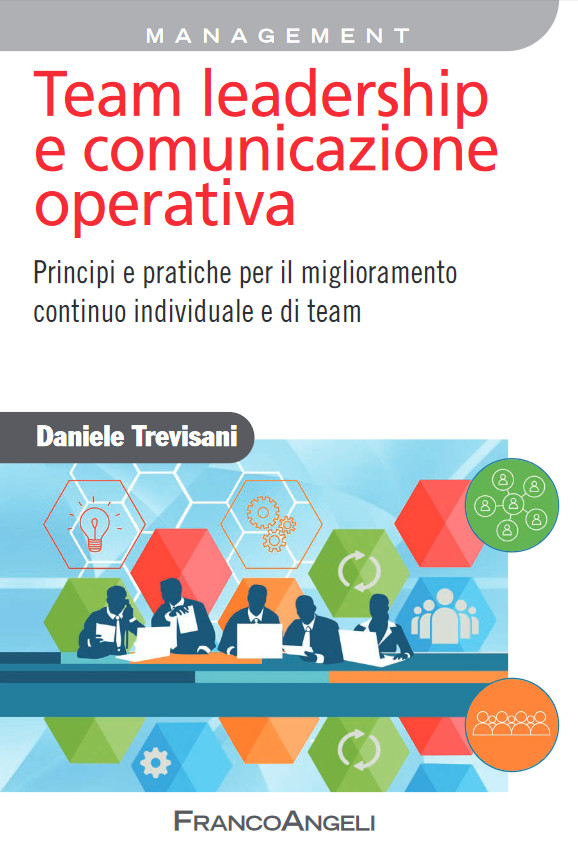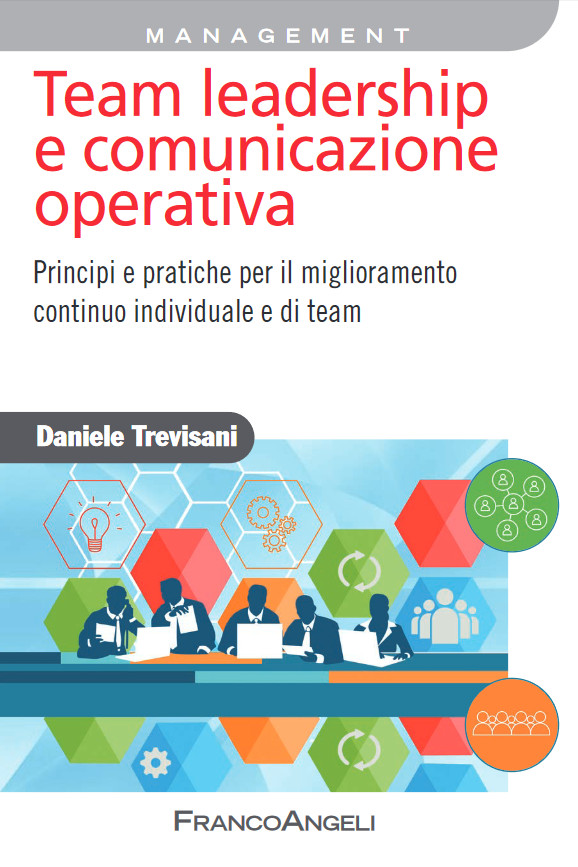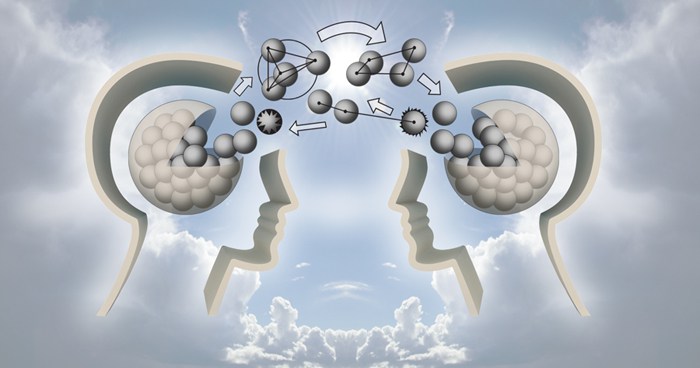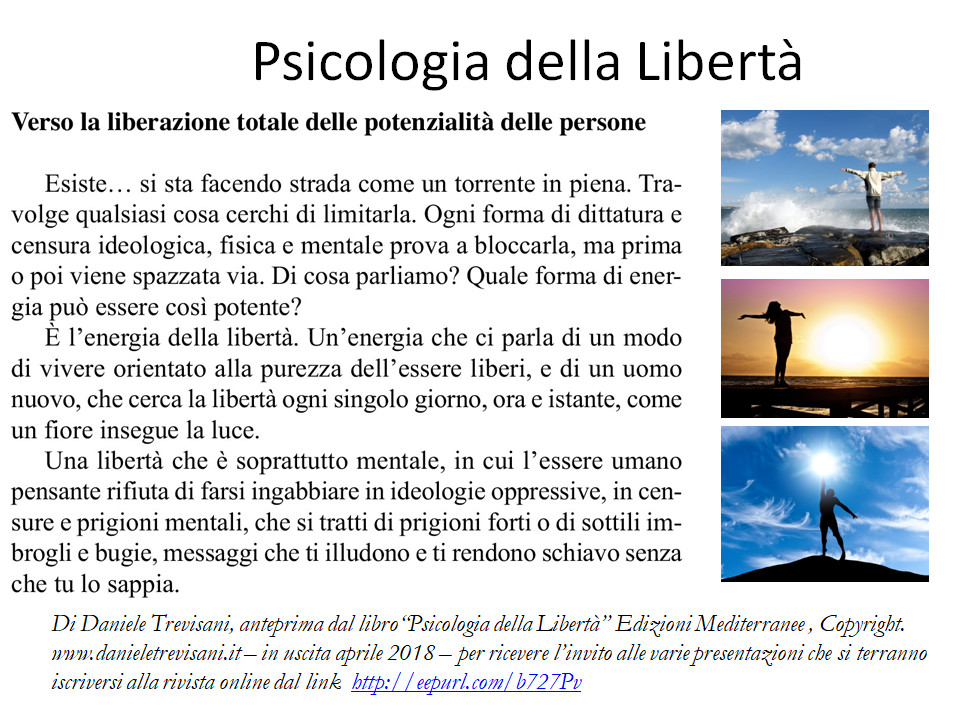Che cosa produce il salto di qualità
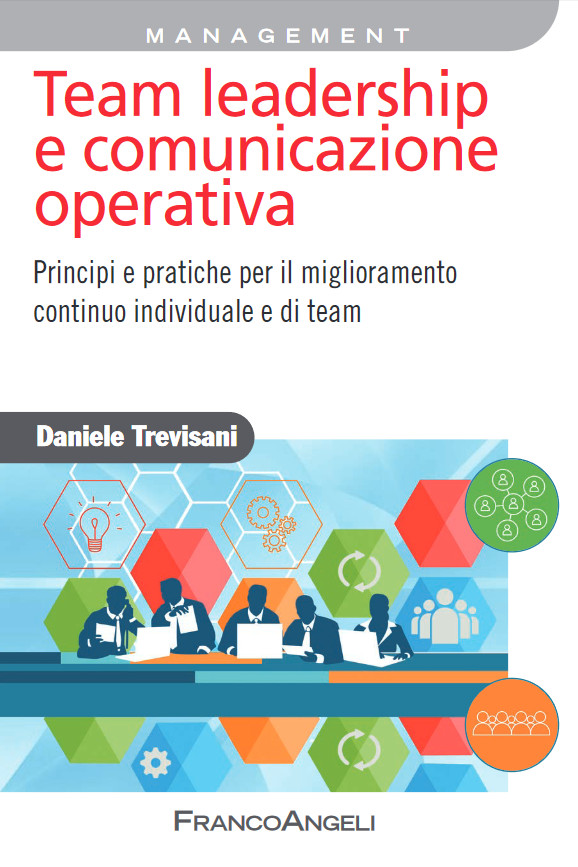 © Daniele Trevisani. Testo estratto dal libro Team leadership e comunicazione operativa. Principi e pratiche per il miglioramento continuo individuale e di team. Franco Angeli editore. Con commenti inediti dell’autore.
© Daniele Trevisani. Testo estratto dal libro Team leadership e comunicazione operativa. Principi e pratiche per il miglioramento continuo individuale e di team. Franco Angeli editore. Con commenti inediti dell’autore.
_______
Il salto di qualità in un team è qualcosa che si vede, si sente, si percepisce. Servono meno parole e la comunicazione è più intuitiva. I linguaggi diventano precisi e chiari, spariscono i fraintendimenti o vengono ridotti al minimo e riconosciuti prima che diventino grandi errori. Si va nella sede dove opera il team con il sorriso e con la voglia di entrare e non se uscirebbe mai. Questo non è un sogno, è qualcosa che ho vissuto tante volte, in tanti posti diversi, in team aziendali e sportivi, per cui è bene estrarne alcuni ingredienti e avviare una riflessione. Questo primo articolo avvia tale discussione sulla leadership di qualità.
________
Una grande varietà di forze speciali, in senso olistico, intese come gruppi ad alte performance, diventa tale quando riesce a compiere il salto di qualità che divide un assembramento di persone da un gruppo di persone estremamente motivate ed efficaci.
- Il primo fattore a rendere speciale un team è la motivazione e senso di appartenenza,
- Il secondo l’addestramento continuo, la formazione continua.
- Un terzo fattore è la consapevolezza delle proprie possibilità.
Ogni individuo si comporta nella vita come se avesse un’opinione ben definita della sua forza e delle sue possibilità; come se all’inizio di un’azione, si rendesse conto della difficoltà o della facilità di un dato problema: in sintesi come se il suo comportamento dovesse derivare dalle sue opinioni (Adler 1933, p. 17).
Dobbiamo quindi fondere un lavoro molto sottile, come l’immagine che un gruppo ha di se stesso, e una persona ha di se stessa, con un lavoro molto pratico come l’addestramento e la formazione su capacità allenabili. Il tutto confluisce nella ricerca di un vero e proprio stile di vita (lifestyle) in cui affrontiamo le nostre paure anziché nasconderci, accettiamo esperienze anche senza la certezza di pieno successo e apprendiamo da esse.
Quando una sconfitta non diventa qualche cosa che distrugge il nostro senso di valore personale e la nostra personalità, quando elaboriamo un piano di vita che cominci ad avere senso, stiamo imparando atteggiamenti che Adler individua come veramente fondamentali per raggiungere risultati duraturi.
Se predomina il puro timore di un pericolo di sconfitta, se il perdere si confonde malamente con un abbassamento del senso di personalità, si cercherà di scappare dalla situazione. Al contrario, un atteggiamento sano consiste nel fatto di applicarsi, studiarla, allenarsi, lasciarsi allenare, cercare risorse ulteriori, potenziarsi, attivare il fuoco sacro del superare l’ostacolo e andare avanti. Questo è un grande salto di qualità.
Se l’ideale di perfezione è una persona che non sbaglia mai, non avremo mai veri leader né veri gruppi, si cercheranno solo vittorie facili e scontate.
Un leader conduce ricerca anche in territori inesplorati, e apprende dagli errori, a volte persino andando a cercare dove sarà il punto di caduta per poi imparare e spostarlo alla prossima occasione un po’ in avanti.
Come riferisce Adler, “ogni epoca culturale forma il proprio ideale di perfezione rapportandolo ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti” (Adler 1933, p. 31). Per cui è davvero il caso di confrontarsi con la cultura che ci circonda e “farla uscire”, attivando quello che oggi nella scienza memetica possiamo chiamare uno “smontaggio” della cultura in cui siamo immersi, o in termini informatici un reverse engineering, andare a vedere con quale software siamo stati programmati e poi riprogrammarci con maggiore coscienza.
Questo lavoro è indispensabile per fare nella vita quello che vogliamo noi e non quello che la cultura storica in cui siamo nati ci dice sia bene o male senza il nostro permesso.
Grandi riflessioni sulla vita si devono accompagnare a grande addestramento del corpo e delle facoltà mentali.
Quando parliamo di “addestramento” non intendiamo l’esecuzione di semplici ordini robotizzati, ma l’interiorizzazione e completa assimilazione dell’azione entro un modo di fare e di essere.
Se non partiamo dal miglioramento di sé e delle proprie capacità, avremmo sempre bisogno di dare istruzioni e ordini, senza mai arrivare al fatto che le persone abbiano la volontà interiore di migliorare e la capacità di dirigere le attenzioni dove serve, arrivando a un’autonomia operativa che toglie il bisogno di essere guidati passo per passo. Il vero salto di qualità in un gruppo avviene quando si ha sempre meno bisogno di dare ordini e sempre più coscienza autonoma di che cosa è bene fare data la situazione, il contesto, la sfida, il compito, lo stato delle cose.
Una Formazione vera deve passare non solo dai concetti ma entrare nell’azione in cui questi concetti possono essere provati, vissuti, toccati con mano.
Il valore dell’esperienza è assoluto, ma serve l’abilità di apprendere dall’esperienza (la “metacapacità” di apprendere dall’esperienza): potremmo cadere senza capire mai perché siamo caduti, potremmo stare male senza capire mai perché e come siamo arrivati a stare male, potremmo persino avere dei risultati ottimi senza capire se è stato frutto del caso o di qualche nostra strategia che possiamo replicare e potenziare. Possiamo vivere una vita come alghe mosse dalle correnti senza mai mettere a sistema nel nostro repertorio di comportamenti le modalità vincenti che invece ci appartengono:
- nelle aziende, possono e devono diventare team speciali i team di progetto che vogliono sviluppare idee e concetti d’innovazione, si concentrano su come progettare un futuro veramente migliore dando vita a progetti nuovi, innovazione vera e non solo su carta o per fini pubblicitari e di propaganda, cui segua il nulla;
- diventano team speciali anche le famiglie che decidono di far crescere figli sani, coscienti e forti, in una società che offre loro modelli malati, una sfida per certi versi enorme;
- sono forze speciali i corpi scelti dell’esercito e altre forze che operano in ambienti difficili e in missioni critiche, rischiando la vita e con sacrificio;
- sono team speciali, in un concetto esteso, le équipe mediche che effettuano interventi difficili che pochi altri riescono a realizzare;
- sono team speciali i team agonistici e sportivi negli sport estremi, che devono trovare il modo di esplorare ogni angolo del potenziale umano, se vogliono sopravvivere;
- sono team speciali i team sportivi anche in sport ordinari, dove la percezione di quello che si fa diventa sacra;
- sono forze speciali gli operatori che agiscono nelle centrali operative, di sicurezza e protezione civile, e devono apprendere l’arte del coordinamento di migliaia di flussi informativi, arrivando a comprendere significati nascosti ai più, per poi trasformarli in decisioni e azioni;
- sono persone speciali e gruppi speciali alcuni gruppi dediti alla spiritualità o alla religione, in cui si giunge alla trascendenza dei limiti umani e alla connessione con valori sovrumani, sovrordinati, percependo un senso dell’universo che sfugge alle persone comuni. Anche la spiritualità ha proprie forme di leadership.
Per essere veri leader serve visione. Ma visione vera, proiettata in un futuro migliore, non solo nel prossimo “trimestre finanziario” come accade troppo spesso nelle aziende.
I governanti pensano a inaugurare garage e centri commerciali, mentre gli scienziati ci dicono che dovremmo preoccuparci di altro.
Da un’intervista a Stephen Hawking, astrofisico:
Domanda. Quale sarà il nostro destino come specie, secondo lei?
Risposta. Credo che la sopravvivenza della specie umana dipenderà dalla sua capacità di vivere in altri luoghi dell’universo, perché il rischio che un disastro distrugga la Terra è grande. Quindi vorrei suscitare l’interesse pubblico per i voli spaziali. Ho imparato a non guardare troppo in avanti, a concentrarmi sul presente. Ci sono ancora molte altre cose che voglio fare (Valenza 2015).
Chi si preoccupa di qualche cosa di più grande di se stesso ha capito il valore della vita. Chi cerca di lasciare un contributo fisico o morale, un lascito che può andare oltre la propria vita individuale, è un vero leader spirituale e morale, gli altri sono solo maschere che abusano di questa parola.
© Daniele Trevisani. Testo estratto dal libro Team leadership e comunicazione operativa. Principi e pratiche per il miglioramento continuo individuale e di team. Franco Angeli editore. Con commenti inediti dell’autore.
_______